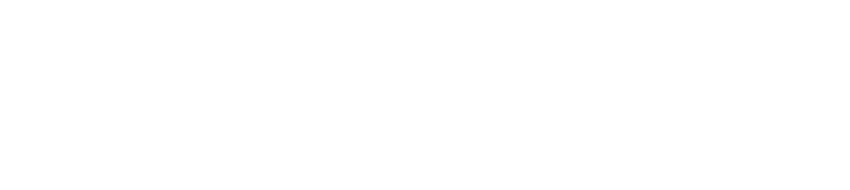
Bellaria, 14 luglio 2025
Quando finiscono gli esami
“Il protagonista ha deciso di non parlare più, poiché ormai si vive in un mondo dove nessuno ascolta più l'altro, dove più nessuno rispetta l'altro.”
In questo passaggio critico su uno dei lavori teatrali forse più conosciuti di Eduardo De Filippo emerge una tragica realtà: già ai suoi albori, nell’era della cosiddetta Intelligenza Artificiale rispetto e disponibilità ad ascoltare caratterizzano il cosiddetto “uomo nuovo”, il quale, sempre più passivo abitante di un “nuovo mondo” dai contorni illusori è destinato ad abdicare a favore di algoritmi complessi gestiti da entità senza volto, senza religione, senza leggi se non quelle calate da un vertice elitario esclusivista (altro che inclusione!). E senza libertà, se non quella di auto-relegarsi nel ghetto dei cosiddetti “complottisti”, i quali vengono spesso etichettati come sognatori ingenui e frustrati, se non come dissidenti più o meno scomodi. O pericolosi. Ma dissidenti rispetto a chi o a che cosa? Rispetto a un mondo OGM in cui dubbie minoranze hanno il sopravvento su interi popoli la cui “colpa” sarebbe quella di provare a dare un senso all’esistenza, cercando nel frattempo di ricavarsi uno spazio infinitesimale nell’universo? Non erano forse complottisti i ragazzi della “Rosa Bianca” e un loro insegnante, la cui finalità era quella di opporsi attivamente al nazismo attraverso la diffusione di volantini che denunciavano le atrocità del regime? Non lo furono forse, “complottisti”, Andrej Sacharov e tanti altri intellettuali perseguitati dal regime sovietico? Per non parlare dei nostri Galileo, Savonarola e Giordano Bruno: il primo ebbe la sfrontatezza di sostenere la teoria copernicana dell’eliocentrismo (“La terra piatta ti sia breve”, recita nel XXI secolo il Pinco Pallino televisivo improvvisando un infelice necrologio, pur sapendo che il Nobel Montagnier era tutt’altro che sprovveduto); il secondo (Savonarola), in quel tempo difficile si era permesso di porre il focus sulla Chiesa corrotta e sull’immoralità dei potenti; il terzo (Giordano Bruno) fu arso vivo perché le sue idee includevano la concezione di un universo infinito e dell’infinità dei mondi, ponendosi coraggiosamente in contrasto con la dottrina cattolica e il sistema geocentrico allora vigente. Furono etichettati come “complottisti” certi giornalisti d’inchiesta che cercarono in tutti i modi di far luce sugli omicidi Kennedy e su altri decessi affatto naturali.
Credo che neppure le menti più pigre riescano a dimenticare gli anni di piombo e la strategia della tensione dietro cui emerge con sempre maggiore evidenza l’implicazione di poteri occulti, forse gli stessi che oggi utilizzano le finestre di Overton per cambiare il mondo, e la società italiana, attraverso passaggi che solo in apparenza rappresentano fasi di processi naturali e inevitabili in quanto tali. Come al tempo del nazismo si parlava di “nuovo ordine”, così oggi si mira a costituire un sistema (quello di cui spesso si parla con preoccupazione in ambito “complottista”) secondo i cui artefici la responsabilità individuale dev’essere drenata verso i diktat dettati dal sistema stesso (“diktat” è un termine tedesco che significa “imposizione”). Pertanto “irresponsabile” diventerà chi (esattamente come nei regimi dittatoriali novecenteschi) non vorrà dare un contributo al cambiamento in termini di finta libertà, finto progresso (se non tecnologico in senso asfitticamente claustrofobico), finta moralità, finto filantropismo, finta scienza (nella misura in cui la gelida “filosofia” di Mengele troverà nuovi accoliti, col neppure tanto sottile benestare del neo-darwinismo e del neo-malthusianesimo), finta giustizia (finalizzata a proteggere l’illegalità rendendola falsamente legittima), finta pedagogia. Riguardo a quest’ultima, siamo sicuri che togliere responsabilità ai giovani si traduca in una maggiore consapevolezza, o in una maggiore capacità di resistere alle durezze della vita in termini di assenza di lavoro e di tutele (sindacali, ecc. ) , nonché di dipendenze varie, come quelle da stupefacenti, da cellulari e da social (sempre più invasivi)? Ricordo una scuola dalle mille, a volte forti emozioni. Come quando ci si doveva preparare per un esame e soprattutto per il colloquio orale, che comportava il dover ripassare con accuratezza vari argomenti, nell’incertezza di incappare in “quello sbagliato” (del resto nella vita le incertezze si sprecano). Non erano forse momenti di crescita? Spesso (ritengo che qui la parola “sempre” sia perlopiù inutilizzabile) anche le delusioni erano funzionali allo sviluppo della personalità, se dalla linea da esse tracciata era ed è tuttora possibile imboccare una strada migliore o più confacente alle reali esigenze del singolo. Pian piano si sta delineando una scuola senza voti, senza esami, forse un domani senza insegnanti (sostituibili da macchine programmate per auto-programmarsi ma sulla base di algoritmi tutt’altro che condivisi, a proposito di)? Credo che di questo passo si andrà verso l’abolizione della scuola stessa, salvo alcune eccezioni riservate ai più abbienti, cosicché il percorso scolastico sarà probabilmente frammentato in corsi professionali online i cui attestati di frequenza (magari ancora con valutazione) potranno rappresentare tasselli di un curriculum vitae che comprenderà momenti di lavoro non remunerato (definiti stages). Si consideri che per certi versi è già così.
La rinuncia agli orali da parte di alcuni maturandi sembra dunque sospetta (stranamente si tratta di tre liceali di tre scuole diverse: il liceo scientifico Fermi di Padova, un liceo di Belluno e il liceo classico Canova di Treviso), nella misura in cui l’episodio sta avendo una risonanza nazionale e “l’assoluzione” da parte di vari “esperti”, soprattutto in materia scolastica. Ma il fatto che gli studenti si dichiarino “oppositori del sistema” mi fa abbastanza ridere, poiché da “complottista sospettoso” ritengo che il ruolo da essi assunto sia invece assai funzionale al sistema neomondista oggi dominante, che mira ad abolire ogni confine e ogni limite in nome di una libertà che comprenda forme di spregiudicatezza tuttora punibili a norma di legge (vedi il caso di Rackete, che ha messo a rischio l’incolumità di alcuni agenti della Guardia di Finanza nell’ambito di una più che sospetta operazione umanitaria, ma il cui operato è stato omaggiato a Bruxelles. La comandante della Sea Whatch 3 viene classificata come ambientalista e attivista e può sembrare improprio associarla alla dottrina iperliberista, eppure iperliberismo e ambientalismo, seppur apparentemente in conflitto tra loro, trovano punti d’incontro sorprendenti. Dal punto di vista liberista, il mercato, se lasciato libero di operare, può incentivare la ricerca e lo sviluppo di soluzioni più efficienti e meno inquinanti. Le aziende, spinte dalla concorrenza e dalla domanda dei consumatori, possono investire in tecnologie verdi per ridurre i costi o per accedere a nuovi mercati, come quello delle energie rinnovabili. Per gli ambientalisti queste innovazioni sono strumenti essenziali per la transizione ecologica. Contraddizioni del nostro tempo).
Ci troviamo dunque di fronte a una farsa collettiva che comprende immancabilmente anche la scuola, in quanto luogo d’inquadramento di matrice iper-liberista (tenendo presente che per iper-liberismo s’intende una forma estrema di dottrina di mercato mirante a una libertà economica pressocché totale e svincolata dallo Stato, il quale non può che imporre limiti allorché voglia mantenere un equilibrio funzionale tra i diversi livelli sociali)? L’iperliberista sa che, al pari di Cappato e della sua azione di sfondamento nell’ambito dell’eutanasia, questi tre liceali (che presto potrebbero diventare molti di più) hanno messo deliberatamente in discussione il “protocollo Maturità”, inteso come insieme di documenti, procedure e misure organizzative che regolano lo svolgimento dell’Esame di Stato. Così facendo hanno rifiutato con l’arroganza di autentici iperliberisti uno schema consolidato che in fin dei conti ha sfornato molti diplomati poi laureatisi (o anche no) conseguendo risultati apprezzabili in ogni campo del sapere.
L’iperliberismo sinonimo di “campo aperto”, insofferente verso limiti e confini anche di natura dogmatico-religiosa, mira spesso a una forma di neocolonialismo economico. In questo scenario le potenze economiche globali, attraverso grandi gruppi e istituzioni finanziarie internazionali come la Banca Mondiale, e come il Fondo Monetario Internazionale che sulla carta dovrebbe avere funzione di sorveglianza e di assistenza finanziaria, esercitano un'influenza dominante sull'economia dei paesi più deboli. Anche conseguenza di ciò è l’insediamento delle multinazionali, che facendo leva su leggi deboli o inesistenti sfruttano la manodopera a basso costo per massimizzare i profitti, ciò che può portare a condizioni di lavoro precarie e a salari molto bassi, nonché a violazioni dei diritti dei lavoratori (coi sindacati sempre più assenti). In step successivi, i paesi così indeboliti diventano facilmente preda di investimenti esteri, rendendosi vulnerabili alle fluttuazioni dei mercati globali e alle decisioni delle potenze esterne.
La perdita di sovranità è tra le conseguenze del processo iperliberista qualora esso prenda forma come baricentro filosofico e pratico dell’economia internazionale: le pressioni esercitate da istituzioni finanziarie planetarie (ne ho citate un paio: Banca Mondiale e FMI), o da accordi commerciali sfavorevoli, possono far perdere il controllo sull’economia e sulle politiche interne. I risultati li stiamo vedendo anche in Italia, dove il malthusianesimo sta vincendo la sua battaglia se è vero che nel nostro paese si continua a registrare un sensibile calo demografico (secondo i dati ISTAT nel 2024 sono nati 10.000 bambini in meno rispetto all’anno precedente, con una diminuzione del 2,6 %). Appare evidente che ciò sia dovuto anche alle difficili condizioni in cui si trovano oggi le famiglie: aumento del costo della vita, stipendi stagnanti o in calo, spese per l’abitazione, precarietà del lavoro, disoccupazione, difficoltà nel risparmio, convivenza fragile dovuta a molteplici fattori, evaporazione di tanti valori che fino a ieri hanno retto la società, carenza di servizi e introduzione di sempre nuove tasse, scenari di guerra in aumento e così via. In questo difficile contesto la scuola è continuamente soggetta a manipolazioni perché si adatti al “nuovo mondo”, ed ecco che dal cilindro del sistema escono questi giovani studenti (spesso gli studenti sono stati utilizzati per fini ideologici!), che, come si diceva, guarda caso, sono tutti liceali ma di Istituti diversi. Nell’immaginario collettivo il liceo rimane la scuola superiore più rinomata e ciò può fare colpo sull’opinione pubblica. Come inizio non c’è male, ma poi arriveranno emulatori anche dagli Istituti Tecnici, professionali e così via. A meno che la politica non mostri la reale volontà di fare argine a questa fuga di buonsenso.
Davide Crociati


